

Bimensile di Informazione e critica d'arte
|
S. De Alexadris - L. Giacobbe - Padiglione Paraguay - R. Peccolo - A. Pizzinato - L. Stocco - A. Talotta - C. Verna - G. Zappettini |
|
|
||
|
novembre-dicembre 2013
|
colloquio con l'artista
Claudio Verna: L'esperienza della Pittura Analitica fu veramente interessante ma come movimento fu molto diverso dagli altri e spesso sento la necessità di chiarire quest'esperienza poiché non riesco a considerare la Pittura Analitica come un gruppo. Tutti i movimenti che sono sorti in Italia, o in altri paesi nel secolo scorso, sono sempre nati da un gruppo molto omogeneo che spesso stava nella stessa città. La Transavanguardia è nata sostanzialmente a Roma e tutti si frequentavano, così l'Arte Povera s'è formata a Torino, il Futurismo a Milano. La cosa fondamentale è che noi non abitavamo nella stessa città, ma siamo stati dei compagni di strada che si sono incontrati quasi casualmente. Griffa e Gastini stavano a Torino, Aricò, Olivieri e Pinelli a Milano, Guarneri e Masi a Firenze, io, Cotani, Morales e Battaglia lavoravamo a Roma, Zappettini a Genova. Non c'è stato un centro che ha fatto da catalizzatore, non c'era un luogo dove ci incontravamo per parlare. Questo ha fatto sì che ognuno continuasse la sua esperienza autonomamente. Certo ci sono state delle tangenze tra noi, e sono state ovviamente notate. Quando negli anni sessanta mi trovai a dipingere vedevo che il mondo dell'arte andava in altre direzioni, così cercai disperatamente chi condividesse la mia ricerca. Qui a Roma trovai Battaglia e Morales. Sentimmo però che le stesse esperienze stavano maturando anche in altre città. L'occasione per conoscere il lavoro degli altri mi venne data da un invito alle mostre di Griffa e Gastini a Firenze. Eravamo già alla fine degli anni sessanta e spinto dalla curiosità andai a vedere come stavano le cose. Lo stesso fu con Battaglia a Roma. Venne a una mia mostra e mi disse: «Sai anch'io dipingo, perché non ci vediamo?». Un'esperienza nata quasi per caso. Ognuno cercava dei compagni con cui confrontarsi. Ma il non parlare e il non vedersi tutti i giorni ha fatto sì che in realtà ognuno coltivasse la sua esperienza abbastanza per conto suo. Abbiamo poi fatto mostre insieme e naturalmente ci siamo visti e frequentati però è mancato sempre un elemento coagulante, o un critico che ci tenesse in contatto, una città che ci ospitasse, mostre che durassero più di un'inaugurazione per parlare.
Diego A. Collovini: Barnett Newman scrisse: «un artista dipinge per avere qualcosa da guadare» e io aggiungo anche di cui parlare. E della pittura aniconica ne parla anche Filiberto Menna nella sua Linea analitica dell'arte moderna. Siete stati aggregati in un gruppo che è stato studiato più attentamente alcuni decenni dopo. Più di qualcuno, e tra quali anch'io, ha sottolineato che non si trattava di un movimento paragonabile alle avanguardie, ma di una serie esposizioni all'interno delle quali il critico di turno teorizzava e interpretava razionalmente le vostre pitture, quasi cercando il quell'esperienza una definizione di tipo concettuale che giustificasse il «ritorno alla pittura»; inglobando anche degli artisti che avevano approfondito le ricerche di altri, allungando a dismisura quell'esperienza. L'intervento del critico, infatti, rispondeva ad una sorta di partecipazione militante, come si diceva negli anni ottanta-novanta, aggiungendo al fare pittura delle teorizzazioni col rischio di categorizzare addirittura la pittura. Ma da sociologo sai che le categorie sono sempre limitative per un artista. C. V. Questo è un aspetto molto importante per cui non ho mai pensato di far parte di un gruppo. E neanche gli altri. Tanto è vero che quando poi hanno cominciato a metterci delle etichette, se fai ben caso, tutti a dire «io non c'entro», «io lavoro per conto mio», tutti a rivendicare un'autonomia. Le etichette all'inizio erano molte Pittura Pittura, Nuova Pittura, Pittura Analitica, ma quasi subito ognuno di noi prese le distanze in qualche modo. In realtà molti punti di contatto c'erano, molto mentali, molto teorici che avevano un senso, non perché le nostre opere si somigliassero.
D.A.C. Penso che se da un lato ogni eccesso di analisi della pittura ha portato a una teorizzazione della pittura stessa, per giustificarne le ragioni del suo essere o di trovare "quel punto" dal quale originare una nuova ricerca, dall'altro però ogni esercizio pittorico ha portato, e ciò lo si nota anche nel tuo lavoro, all'espressione lirica del colore e, attraverso le trasparenze e le velature, ognuno per se stesso ha voluto dare forma ad una nuova idea di pittura. C.V. Quando la pittura venne messa in crisi, anzi negata, si viveva la necessità di uscire dal quadro. Io, pur avendo sperimentato lo spazio reale, decisi di rimanere nel quadro, di lavorare nello spazio virtuale della tela. Non ho cercato un azzeramento, sono ripartito mettendo un mattone sull'altro e ho fatto quadri di un solo colore. Negli anni '68, '69, '70, ho dipinto con un solo colore perché se io sulla stessa superficie da una parte stendevo una mano di colore e dall'altra ne sovrapponevo tre, creavo un triplice ordine di rapporti: chiaro-scuro, lucido-opaco, caldo-freddo; giocando su un unico colore partivo da una base elementare. Cosa faceva Griffa, che mi è vicino culturalmente e teoricamente? prendeva una tela e ci faceva delle aste come i bambini, anche lui ricominciava da capo: non ha usato un solo colore ma è ripartito da un gesto elementare. Si trattava di «riavviare la pittura» con segni elementari, come tracce della tua storia. Per me indagare gli strumenti della pittura è ancora fondamentale.
D.A.C. Potremmo condividere, seppur nella sua generalizzazione, la definizione di Celant usata nel 1967 quando parlando di alcuni artisti americani, fra i quali Martin e Ryman, scrisse di una «pittura che da sistematica si fa analitica». Una pittura che muove dunque da un linguaggio come forma di espressione, per trasformarsi in un linguaggio in grado di guardare a se stesso, di ripensare la pittura come una forma linguistica valida non per ciò che può raccontare o descrivere, ma per la sua potenzialità espressiva autonoma, ragionando anche sul fare pittura, sul procedere materialmente, sulla pratica, creando così una sorta di esercizio della pittura che palesa l'analisi delle componenti che caratterizzano il linguaggio pittorico in quanto tale e il processo attraverso il quale la pittura si materializza. C. V. Nel periodo i cui si negava la pittura, io che facevo pittura, osservavo benissimo gli altri tant'è vero che tra gli artisti che stimo ci sono, a ragion veduta, Castellani, Kounellis, soprattutto Paolini. Menna mi disse «Tu sei il Paolini della pittura», «sei il concettuale della pittura». «Assolutamente no» risposi «non facciamo quest'errore, l’arte concettuale ha un senso è un'idea che contiene tutte le possibili realizzazioni, le varianti possibili: insomma conta l'idea dell'arte e non i modi in cui storicamente si manifesta.» Per me è assolutamente fondamentale unire i due momenti: pensare e fare. Non faccio una didascalia a un'idea, io trovo le strutture di un'idea dipingendo. Quindi i due momenti, quello razionale e quello del fare, sono per me la stessa cosa. Non sono assolutamente un concettuale, la mia componente mentale è totalmente diversa da quella concettuale. Il quadro funziona quando i due momenti della razionalità e dell'abbandono creativo, trovano un punto d'incontro; se prevale l'aspetto razionale il quadro è freddo e non mi piace, non mi assomiglia assolutamente. Se è invece troppo abbandonato, e a volte mi succede, si fa informale e rischia di diventare una pittura solipsistica. Sono consapevole del mio lavoro, perciò mi accorgo quando l'ida mi è entrata nelle braccia. In quel momento mi posso anche abbandonare, ma comunque la libertà è una cosa che si conquista lentamente.
D.A.C. Guardassimo al passato, alle opere tra gli anni '64 fino al '78, '79 riscontreremmo una specie di pausa nel tuo lirismo, in quell'atteggiamento di libertà nel seguire il movimento e il colore. Potremmo pensare che quella pausa sia un momento di riflessione e di ricerca o un ragionamento sulla forma, una sorta di supremazia del razionale sull'emozionale. Diceva Accame a proposito dello spazio fisico e mentale che nei tuoi quadri «la sensualità cromatica è sempre espressione pienamente intellettuale e l'intervento concettuale conterrà sempre la misura sensibile da cui ha origine»; certamente questo a seguire quanto Menna aveva scritto: «L'operazione [di Verna] è condotta in maniera sistematica, scartando ogni intervento casuale e seguendo una sequenza ordinaria in modo da evitare ogni trucco, ogni astuzia, ogni scorciatoia». C. V. Ho sentito la geometria come un limite, quasi dovessi dimostrare che ero intelligente, che avevo capito le cose. Non sai quanti quadri ho distrutto perché avvertivo questo limite; naturalmente ne ho tenuti anche tanti altri. Alla fiera di Basilea ho avuto richieste essenzialmente da collezionisti americani per opere di quel periodo. E mi chiedo cosa vedono in quei quadri. Mi sono accorto che pur nel momento della massima razionalizzazione, del massimo aspetto progettuale, una cosa salva quei quadri e mi riguarda profondamente: cioè tutto il mio lavoro si basa sostanzialmente su un unico elemento fondante che è il colore. Ciò si avverte anche in uno dei quadri più freddi che ho fatto “A 44”, è del 1971 e fra poco andrà negli Stati Uniti. È un quadro giallo, ma è un giallo forte, talmente sparato che ha una particolare forza emotiva, addirittura erotica. Raffigura lo slittamento della superficie su altre superfici: una è quella della tela, una è dipinta e una è quella tratteggiata. Sono tre slittamenti che originano ambiguità, tema per me è fondamentale. Un mio limite è stato guardare quei quadri troppo sotto l'aspetto razionale o progettuale: invece c'è dentro ciò che mi identifica: il colore.
D.A.C. Le corde del vento, Senza parole, Sull'obliqua dei pieni, Il chiaro lo scuro, Il gorgo e l'artificio. Sono titoli di alcuni tuoi quadri. Si avverte un legame tra il senso della pittura e quello del suono; il titolo dunque, come componente dell'opera. Mi accorgo che non c'è legame tra il senso delle parole e il senso della pittura ma si avverte un completamento come se tempo e fare si chiudano in un significato altro da ciò che si vede. C. V. L'argomento sui titoli mi affascina. Per un periodo ho chiamato i quadri A1, A2, A3, fino a A200 (acrilico 1 ecc.) proprio perché non volevo che il titolo evocasse una sorta di racconto; così identificavo il mio lavoro come uno sviluppo e i numeri davano il senso dell'evoluzione. Quando mi sono sentito più libero di fare pittura ho cominciato, a metà degli anni settanta, a titolare i quadri solo Pittura. Poi mi sono accordo che c'era ancora qualcosa di più e ho cominciato a dare dei titoli che non dessero la spiegazione del quadro, assolutamente, ma che facessero parte del quadro, diventassero un elemento del quadro e non una descrizione o soltanto un appunto per ricordarlo. Un titolo che avesse a che fare anche con la mia storia. Per esempio, dopo sei mesi non avevo dato un titolo a un'opera, così l'ho chiamato Quadro in cerca di un titolo. Quando soffrivo d'insonnia ho dipinto Quando speri che sia finalmente giorno, oppure un quadro come il Muro degli uccelli che è un omaggio a de Staël. Ora il titolo a volte è un mio diario, la rievocazione di un verso che mi piace o che magari non ho capito ma che mi ha intrigato. Non ho mai intitolato i miei quadri Senza titolo. Per chiarire meglio l’importanza dei titoli, ti faccio l’esempio di un’opera di Giulio Paolini “Giovane che guarda Lorenzo Lotto”, una teletta in bianco e nero fotografica esposta a Roma negli anni 70. Ne volevo comprendere il significato senza leggere il titolo; l'ho guardata, l’ho riguardata e mi chiedevo cosa volesse dire, che significasse, perché quella tela emulsionata mi interessava così tanto. Poi lessi «Giovane che guarda Lorenzo Lotto», un'immagine tratta da un quadro di Lorenzo Lotto. In quel momento diventai io Lorenzo Lotto e feci un salto di quattro secoli. Ho avuto una vertigine assoluta, un viaggio nel tempo e nello spazio: io diventai Lorenzo Lotto. Fu una delle emozioni più grandi della mia vita. In quel caso il titolo è fondamentale. È l'opera.
D.A.C. Come il titolo entra nell'opera attraverso il suono, anche la luce si forma e vive nelle tue pitture attraverso il colore e attraverso il tempo, che poi disegna il divenire dell'atto pittorico. Come un esercizio infinito della pittura che si espande non nell'opera chiusa e virtuale del quadro ma che continua nel tempo, sommando esperienze e riflessioni, come se il colore dialogando con la luce acquisisse nuove espressività superando ogni ristrettezza dovuta alla limitatezza dell'opera finita. C. V. Uso un termine che non ho mai capito se esiste: marezzatura. Penso all'increspatura del mare quando non ci sono le onde, alla vibrazione della superficie. Cerco sempre questa vibrazione soprattutto con l'acrilico. Io sono molto veloce quando dipingo, però dipingo un quadro tante volte, lo cancello, lo riprendo, lo rifaccio. Il quadro finito, anche se è solo un arancio e basta, deve mantenere la memoria di tutto quello che c'è dietro, delle tracce, dei segnali. Un critico disse una volta: «quell'indizio che l'autore ci ha lasciato». Il mio quadro Grande arancio è apparentemente dipinto solo con un arancio, ma senti che è vissuto, che dietro ci sono tutte le immagini possibili, che contiene tutte le figure del mondo, tutti i colori del mondo. Il fatto che lo dipingo tante volte rende lento il mio lavoro. Oggi, dei segni e delle croci identificano lo spazio e curiosamente, ad osservarli bene, sono simili a quelli degli anni settanta; il mio lavoro va a spirale. Ci sono tangenze con tutto il lavoro che ho fatto e mi piace rimettere in gioco tutto, e lo faccio finalmente senza ansia, con una grande libertà. Voglio essere libero.
D.A.C. Io chiuderei citandoti: «il vero quadro è sempre dietro quello che appare.» C. V. Ne sono convinto: il quadro vero non lo vedi mai e non lo vede nessuno o solo una persona straordinariamente intelligente o brava, perché quando fai un quadro ci metti in realtà tutte le tue intenzioni, le tue voglie, i tuoi amori, poi le cose che detesti, ma le vivi talmente in prima persona che poi ne rimani anche in qualche modo vittima. E poi il contesto, il tempo, il momento in cui lo fai. Nel quadro “A 44” io vedevo soltanto le tre superfici e non vedevo assolutamente la forza emotiva del colore: adesso la vedo! Hanno ragione quelli che l'hanno notato perché in realtà la cosa fondamentale è questa forza, perfino eccessiva, di questo giallo. Per tanti motivi non si vede il vero quadro, perché si è condizionati da troppe cose, dal contesto, dalla tua storia, da te stesso. La vera opera non la vede nessuno nemmeno lo scrittore, il musicista, né il regista, neanche il critico più intelligente. È sempre dietro, è sempre una cosa che non vedi subito fino in fondo. Io ho visto com'è cambiata la lettura dei miei quadri. Un critico è arrivato a scrivere, a suo tempo, che i miei quadri erano troppo freddi e, a distanza di vent'anni, ha detto che sono barocchi. La percezione dei quadri non cambia in vent'anni, poi sembra cambiare in pochi attimi perché sono mutati il clima, le mode e, quindi anche il modo di guardare la pittura.
D.A.C. È questa la liricità cui alludevo.
|
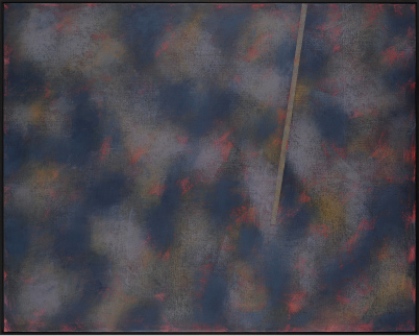
|
|
novembre-dicembre 2013
|
Intonazioni Liriche tra materia e colore Palazzo Brusarosco - Vicenza
Nell'appartamento restaurato e ridisegnato da Carlo Scarpa nel palazzo Brusarosco a Vicenza, dove è anche ospitata la biblioteca, Laura Stocco ha esposto un considerevole numero di opere che abbracciano quasi la totalità del suo percorso artistico. Già il titolo Intonazioni liriche tra materia e colore è un primo indizio per una lettura omogenea, che non si sofferma sull'aspetto formale delle opere esposte, ma si profila come un'indicazione per muoversi all'interno della sua ricerca pittorica. Colore, sì ma non solo, materia sì ma non univoca, forma, sì ma non in un'ottica della ripetizione delle forme e dei suoi cromatismi. Dunque elementi singoli – poiché così si manifestano – che dialogano tra loro a volte con stili dissimili e non tali perché nel lungo percorso creativo di Stocco esistono differenti periodi linguistici o mode espressive raccolte nell'ambiente artistico, ma perché anche in Laura Stocco la ricerca a volte si è trasformata in una riflessione che nel tempo è andata maturando. Proprio per questa lenta formazione la sua ricerca ci appare ancor più raffinata; come la sua sintassi creativa fa dialogare i diversi elementi del suo linguaggio astratto rendendo poetico e lirico ogni effetto cangiante del colore che accompagna l'apparire della luce. Questi effetti sono replicabili da Stocco grazie alla sua personale interpretazione della materia; composita, mai unanime (con la stessa anima) e costituita da vari elementi: piccoli sassi, vetri dai vari cromatismi, tutti sminuzzati. A questa materia lucida e riflettente l'artista amalgama opache terre, sabbie raccolte in ogni parte del mondo. Però soffermare la nostra attenzione alla sola materia sarebbe difficile, oltre che riduttivo, poiché la materia, per l'artista vicentina, non rappresenta un elemento a sé stante ma il corollario, assieme al colore, dell'epifania della luce, in improvvisi riflessi generati dalla sua essenza materiale e che inducono a pensare a un mondo metafisico da cui origina la luce. Non dunque la luce come espressione di un complesso sistema cromatico né come espressione di una forma o di un volume. Per Laura Stocco la luce è lo strumento che dà identità al colore e consistenza strutturale alla forma. Così le sue forme semplici (quadrati, rettangoli, tondi ecc.) o complessi come le nebulose (metafore di un mondo più ampio che non si chiude solo nel momento della visione ma che induce a guardare all'infinito) sono strumenti di un dialogo con la luce che mai appare uguale a se stessa; una luce sempre cangiante ricca di riverberi nei quali si alternano opacità e brillantezze disegnando un infinito spazio dove a illusorie profondità si alternano altrettanti fonti luminose. Quasi ad approfondire quelle visioni metafisiche dello spazialismo veneziano che in gioventù ha direttamente conosciuto e dal quale si è fatta affascinare. Un linguaggio espressivo che ha poi voluto evolvere in forma personale anche confrontandosi, negli anni più maturi, con alcuni dei protagonisti di quella esperienza.
|
|
|
novembre-dicembre 2013  |
Il Palazzo Enciclopedico del Paraguay
Palazzo Carminati
LV - Biennale Internazionale d'Arte di Venezia
Il palazzo enciclopedico è il tema della Biennale di Gioni. Appropriato alla realtà artistica e geografica che la manifestazione vuole divulgare. Venezia e i suoi palazzi, le sue nobili dimore, le sue vecchie strutture produttive (per prime proprio le corderie dell'arsenale) sono chiamati a essere i contenitori del sapere enciclopedico. Palazzo Carminati ospita il padiglione del Paraguay, che per la prima volta si affaccia con i suoi artisti sulle rive della Laguna. Quattro gli invitati Pedro Barrail, Daniel Milessi, Diana Rossi e Félix Toranzos, scelti da Osvaldo Gonzalez Real; comissario Elisa Victoria Aquino Laterza e l'allestimento di Tiziano Inguanotto. You are not here; questo scrive Pedro Barrail su un gran tondo rosso collocato al centro del salone nobile. Una concettualizzare della realtà nell'interpretazione dell'essere in un surreale tempo; un dialogo tra lo spazio vero e quello virtuale, qui rappresentato con una grande fotografia che nasconde alla vista il luogo nel quale materialmente vive l'opera. Il reale tangibile è vissuto nella falsa percezione dei sensi in un mondo ambiguo tra vero e vissuto. L'artista propone ancora il tema del punto di vista. Ciò che percepiamo è solo un attimo del nostro essere in un luogo reale o virtuale; ciò che resta è l'esperienza. Il video di Daniel Milessi Yasururu Sororo (invasione) si configura come una onirica interpretazione della storia del paese di Guarani (il Paraguay appunto). Protagonista è il susseguirsi delle invasioni del continuo spodestamento delle civiltà. E ciò che di queste rimane sono le cose ordinarie e quotidiane che si trasformano in feticci. Irrealtà come il video, irreale in quanto vuol riproporre la storia da un altro punto di vista. Una narrazione sempre nel divenire della storia però figlia del tempo immaginario e degli eventi che, appena accaduti, già si accasano nella memoria e attraverso l'umana narrazione rivivono il loro ria-accadere. Quanto si conosce della propria storia? Diana Rossi affonda la sua memoria nella preistoria in quella testimonianza fossile del formichiere (“yurumi”), animale totemico della tribù indigena Ache-Guayaki del Paraguay. Altri oggetti (ossa, fili di pollaio, scarti di cuoio, bottiglie di Coca-Cola), si innestano in questa storia come testimoni di un determinato tempo e distinguono il susseguirsi delle civiltà. Feticci di un'epoca, simboli di una società che si raccontano in differenti punti di vista; feticci che disegnano la metamorfosi culturale delle società a partire proprio dai primi abitanti di quelle terre lontane. Ancora il tempo occupa il lavoro presentato da Felix Toranzos (significativo pittore molto attento alle tradizioni astrattiste americane degli anni sessanta e settanta, quando gesto, colore e materia erano gli elementi principali della sintassi pittorica indirizzati all'interpretazione della luce) che in questa mostra presenta, con taglio figurativo, elementi architettonici che richiamano il palazzo dell'orologio l'Horologion, di Andronico di Cirro (fine I secolo a.C.). Una costruzione che riaffiora dalla terra duemila anni dopo, per diventare nella trasfigurazione dell'attualità il tetto del Museo Nazionale di Belle Arti di Asuncion: altro punto di vista. Anche Il Palazzo dei Venti segna il divenire della storia rincorrendo la metafora del vento. Le forme geometriche, raffigurate in ampi pannelli dal guardano al Rinascimento, richiamano le formule magiche qui raffigurate coi numeri o dalle geometrie di ispirazione ermetica conseguenti alla più pura tradizione pitagorica. Gli artisti sono accomunati nella narrazione del divenire del tempo e delle azioni umane attraverso la testimonianza della storia sempre però dipendente da una percezione individuale. Un tempo che forse si è perduto e che solo attraverso il linguaggio dell'arte è possibile rappresentare nel suo evolversi e nel suo essere presente come momento di una memoria che fa sentire l'uomo assente: You are not here.
|
Felix Toranzos Pedro Barrail |
|
giugno - luglio 2013
|
parlando della pittura
Diego A. Collovini - In molti scritti dei protagonisti delle esperienze pittoriche degli anni settanta viene citato spesso un leitmotiv che più o meno suona così "dipingo per avere qualcosa di cui parlare"1, come se la pittura o il pitturare non sia sufficiente a se stesso, ma sia invece il primo passo per il superamento della pittura stessa verso una riflessione più concettuale. Anche nei suoi scritti si avverte la necessità di superare la fase per così dire "manuale del fare" per cogliere gli aspetti analitici dell'oggetto pittura. 1 La citazione esatta è «un artista dipinge per avere qualcosa da guadare», Barnett Newman, “The Tiger’s Eye”, 1947
Gianfranco Zappettini - Molti nel corso degli anni hanno affrontato i miei scritti teorici – come quelli di molti miei colleghi – come se fossero un completamento, addirittura un superamento della fase pittorica. Come se al pittore la pittura non fosse sufficiente per esprimersi, ma dovesse aggiungere una sorta di parafrasi scritta. In realtà, almeno per quello che mi riguarda, lo scritto non supera la pittura, se mai la precede, o la affianca, o la appoggia. Negli anni settanta in particolare, scrivevo per esplicitare il processo che mi aveva portato a realizzare quelle opere. I miei testi funzionavano più o meno tutti allo stesso modo: dichiaravo cosa avevo inteso fare, di quali materiali mi ero servito e perché proprio quelli, di quante fasi lavorative avrebbe dovuto comporsi la sessione, che tipo di risultato mi attendevo. Era una sorta di verbale della sessione lavorativa, più che di scritto teorico. Certo mettere nero su bianco tutto ciò era un bell’aiuto che davamo alla critica, anche se non nascondo che spesso abbiamo scritto noi in prima persona proprio perché della critica dell’epoca non nutrivamo grosse aspettative: confusione ne avevamo già vista tanta.
d.a.c - Testimonianza del "massimo del distacco" dalle esperienze artistiche pittorico-informali (e con queste intendo tutte le scuole dell'arte astratta che muovono dalle prime sperimentazioni aniconiche di Romolo Romani, all'espressionismo astratto americano, alla pittura astratto–concreta, geometrica, gestaldiana o cinetica ecc.) sono le sue opere della seconda metà degli anni settanta, riconducibili al ciclo "processo tra foto e pittura nei tempi a-b-c-d…". Un'estraniazione dall'azione dell'artista per focalizzare una creatività più vicina a un'azione percettiva che spetta allo spettatore, tramite l'azione testimoniale della macchina fotografica. Questa respinge ogni materializzazione della pittura, e la trasforma in altro dalla pittura, in fotografia appunto, senza con questo essere una mera riproduzione dell'opera pittorica. La pittura diventa, a tutti gli effetti, oggetto di analisi, non nel suo divenire o formarsi ma nel suo essere come un oggetto autonomo. D'altronde per analizzare un oggetto nella sua essenza è necessario estraniarlo dal suo contesto, tagliare il cordone ombelicale che lo lega ad altre situazioni. G. Z. - È vero, la macchina fotografica non mi ha attratto per la sua capacità “riproduttiva”, quanto per la sua capacità di aprire un nuovo livello di operazioni. Intervenivo con un segno minimale (una piccola campitura, una linea, il punto), che fotografavo, ingrandivo e sviluppavo: a quel punto, così straniato da se stesso, l’intervento pittorico diventa a sua volta un campo d’azione per un nuovo intervento: in pratica, dipingevo sulla pittura. Le tesi di Zolkovsky mi avevano senza dubbio insegnato questo: che dall’amplificazione come lui la intendeva si poteva salire ancora di un gradino e rendere tutto il processo in una dimensione nuova. La base della Pittura analitica, così come l’aveva formulata Honnef nel 1974, poggiava su queste teorie, più vicine a Chomsky che ad Argan. Non ci aspettavamo che tutto il mondo dell’arte fosse pronto – e infatti non lo era – ma che fosse chiaro quanto ci differenziava dalle altre astrazioni (informale, geometrica, basso-percettiva): la Pittura analitica, anche quando utilizzava la macchina fotografica, era un’indagine sul linguaggio-pittura, svolta coi mezzi della pittura stessa, al pari della linguistica, che usa la lingua per indagare sulla lingua.
d.a.c - Alla luce delle sue considerazioni possiamo ritenere che gli elementi linguistici della pittura (anche quella erroneamente intesa come pura espressione dell'io più interiore dell'artista) si assottigliano e rimangono esclusivamente quelli minimi perché si possa ancora parlare di pittura: la superficie e un colore, nel suo caso il blu (che a me ricorda il Giotto della Cappella degli Scrovegni) e il bianco come testimonianza della luce. Comunque sufficienti per costruire una minima sintassi della pittura che, come lei dice, non deve essere "contaminata da teorie derivate". È questo il senso del grado zero della pittura? G. Z. -C’è differenza tra le mie opere degli anni settanta e quelle degli anni duemila. Allora mi interessava l’analisi del linguaggio pittorico, scomporre la grammatica della pittura negli elementi minimali e ricostruire in discorso. Era quello che sentivo necessario, dopo l’azzeramento che l’Arte Concettuale aveva tentato nei confronti della pittura: Kosuth aveva detto di non comprendere chi tra i suoi colleghi artisti ancora «pensava in termini di pittura», io feci di questo «pensare in termini di pittura» il mio vessillo, perché non credevo che il futuro ci avrebbe riservato un’arte senza pittura – e come si può vedere oggi, avevo ragione io, e torto Kosuth. Inoltre, la pittura doveva essere scomposta, azzerata e rigenerata perché negli anni settanta tutta la società doveva passare attraverso questa “rivoluzione”: non dimentichiamoci che anni furono, quelli. In Francia, i miei amici Viallat e Dolla di Supports/Surfaces, corrente parallela alla Pittura Analitica, avevano capito che il pittore non poteva essere messo da parte ma che poteva avere un ruolo anch’egli nella “rivoluzione” che si teorizzava. Nel suo piccolo il pittore doveva rivoluzionare la pittura, tornando alle sue radici ontologiche, alla sua ragion d’essere, abbattendo le sovrastrutture accademiche, leziose, sentimentali, autobiografiche che avevano portato la pittura sull’orlo del precipizio. Il bianco era allora per me il “colore-non colore”, la somma di tutti i colori che però non allude a nulla: era niente più che uno strumento, come il rullo da imbianchino, o la grafite. Oggi mi interessa il valore simbolico della trama e dell’ordito, che è – se vogliamo – un ulteriore livello di analisi: tant’è vero che “testo” e “tessuto” hanno la stessa etimologia, il latino “textus”. La pittura, meglio la superficie, è una tessitura, così come uno scritto è una tessitura di parole (non a caso si parla anche di “intreccio” per riferirsi alla narrazione). Allo stesso modo mi interessano altre simbologie, comprese quelle dei colori. Il blu delle opere della prima metà degli anni duemila rappresenta la notte cosmica, la “Via di Mezzo” tra il bianco della Manifestazione e il nero della Non-Manifestazione. Ma da allora ho affrontato anche altri colori, come per esempio il rosso, il simbolo della passione ma anche della gnosi, cioè della conoscenza “secca” che si contrappone a quella “umida” della mistica. Al bianco sono tornato da un paio d’anni, segno che un giro della mia spirale della vita è stato percorso e un nuovo giro si apre.
d.a.c - Penso che le sue opere vogliano lasciare lo spettatore solo pronto a dialogare con la pittura; non di fronte ad una significanza (dove da sempre la pittura si è persa) ma a un oggetto che non spiega ma interroga, che non chiede di essere capito ma di essere guardato in quanto forma; la quale, in quanto tale, è la vera espressione della creatività dell'artista. G. Z. -Sì, credo che sia giusto dire che lo spettatore è solo. E anche che di fronte alle mie opere non può far altro che dialogare con la pittura: l’obiettivo, fin dagli anni settanta, era far sì che lo spettatore si percepisse nell’atto di percepire, che capisse cioè di essere “un uomo che guarda un oggetto chiamato quadro”, cosicché quell’oggetto appeso alla parete non potesse più definirsi “ritratto” o “paesaggio” o “interiorità dell’artista” bensì semplicemente “quadro”. Sulla creatività la pensavo all’epoca come la penso oggi: la pittura non è una tela bianca su cui sbizzarrirsi e sfogare il proprio estro, è un meccanismo che allora chiamavo “processo” e oggi preferisco chiamare “metodo”, ma che rimane una serie codificata di fasi con l’unico obiettivo di perpetuare un linguaggio. Se proprio devo fare un paragone, mi paragonerei volentieri a un monaco amanuense del Medio Evo, che copiava i testi degli antichi a beneficio dei posteri. Era creativo? Sì, forse sì, ma nei limiti del lavoro che gli era imposto da quella superiore missione.
d.a.c - Non so se le sue opere possano essere definite dei corpi cromatici (cromatici non nel senso che rappresentano una gamma di colori, ma in quanto superfici dipinte) poiché presentano una minima tridimensionalità; questa apparente "tridimensionalità frontale" però esclude un ragionamento sulla sola superficie, mentre la serialità, con la quale vengono proposte le sue opere, credo intendano negare ogni evoluzione di tipo temporale, un prima e un dopo. G. Z. -È una domanda complessa, sulla quale vale la pena di soffermarsi. La parola corpo è accettabile se la pensiamo come “corpus”, cioè un insieme che raccoglie vari elementi: come detto prima, credo che un dipinto sia proprio questo, un insieme di fasi e materiali che attraverso il processo/metodo si coagulano in un oggetto autoreferente. Del cromatismo ovvero del significato che avevano e hanno per me i colori, ho già detto sopra e credo di non dover più tornare. Il problema della “tridimensionalità frontale” è una linea di ricerca che non ho certo inaugurato io, ma che mi ha sempre affascinato fin da quando ad Albissola frequentavo lo studio di Fontana. Capire fin dove ci si può spingere con le tre dimensioni senza sforare nella scultura, o nell’oggetto-oggetto, ma rimanendo in un’opera pittorica, è quanto mai interessante ancora oggi. Nella serie della Trama e l’Ordito credo di aver capito che la tridimensionalità può in fin dei conti essere letta come un problema di vicinanza o di lontananza dall’opera: quello che vedo è sempre una superficie, ma se ingrandisco scopro i vari livelli di tessuto, e nello stesso quadro riporto vari livelli di profondità. Sulla serialità, è proprio come dice lei: anche negli anni settanta non c’era alcuna evoluzione dell’opera, se mai la sua perpetuazione ciclica all’infinito. Ho fatto mostre con decine di “Tele sovrapposte” delle stesse dimensioni, una affianco all’altra, tutte apparentemente identiche l’una all’altra ma tutte diverse perché fatte a mano: quel che mi importava – e che oggi viepiù mi importa – non erano le opere, ma l’Opera.
d.a.c - Le sue ultime opere mi pare vogliano parlare maggiormente di pittura, o meglio del colore, non in quanto espressione di un cromatismo ma come materia, come pellicola, come strutturazione cromatica, come strumento del fare, ecc. Le sovrapposizioni, le diverse mani di colore, le trame e gli orditi, le reti sottostanti, le mancanze di colore in un lato, il degradare della pittura che fa apparire il substrato pittorico (idea di non finito ma anche di stratificazione temporale delle diverse azioni del dipingere) sembrano elementi che riconducono all'idea primaria di pittura: pittare, fare pittura. Si potrebbe definire, quest'ultima fase come il superamento di quel grado zero della pittura? Non più la riduzione minima della pittura ma il punto di partenza per fare nuovamente pittura. G. Z. -In parte è così. Il grado zero della pittura di cui parlavamo noi Analitici negli anni settanta era la declinazione pittorica del grado zero della scrittura propugnato vent’anni prima da Roland Barthes. Dovevamo arrivare non tanto a una tabula rasa, ma a un momento in cui tutti gli ingranaggi del meccanismo pittura fossero stati smontati e pronti per essere rimontati. Già la Pittura analitica, dunque, era un nuovo “grado uno”, una ripartenza, la rigenerazione di un linguaggio. E questo non poteva prescindere dal colore, inteso come lo strumento di cui di serve il lavoratore-pittore, quello di cui è sporca la sua camicia da lavoro al termine della giornata. Sporcarsi col colore era fondamentale: noi eravamo (e siamo) pittori, non “operatori visuali” come si definivano i Cinetici e i Gestaltici. Noi dipingevamo, coloravamo superfici, ci sporcavamo, usavamo attrezzi con le mani: la componente manuale del lavoro non è mai stata in discussione, non avevamo alcuna intenzione di servirci di assistenti per demandare il “lavoro sporco”, perché – parafrasando De Amicis – per noi il “lavoro non sporca”, se mai nobilita. Perciò se diamo questo senso a quel che dice lei chiama “pittare”, sì, sono d’accordo, ma era già vero negli anni settanta.
d.a.c - L'utilizzo del rullo ha da sempre sottolineato una sua distanza dall'azione del dipingere (anche per non cadere in significanze psicologistiche risalabili al segno in quanto espressione di una certa gestualità). C'è però in alcune sue opere, riconducibili al ciclo Al fine che traspare, una presenza del segno. Benché si tratti di un segno controllato e dialogante con la matericità del colore e con le sue diverse intensità, appare comunque tale da negare alla superficie un ruolo esclusivo di puro elemento linguistico autonomo per trasformarlo nel "luogo della pittura". G. Z. -In quella serie il protagonista più che il segno è la traccia. I segni di cui parla lei sono le tracce lasciate dall’uroboro, il serpente simbolico che è spesso associato all’alchimia. L’uroboro si morde la coda, creando così la figura di un cerchio che vuole alludere alla ciclicità di tutte le cose: da una cosa che muore, un’altra ne nasce, e qui torniamo al problema della ciclicità di cui dicevamo prima. L’uroboro striscia nella notte (il blu scuro, ovvero la Non-Manifestazione) e smuovendo la polvere del deserto evidenzia ciò che deve essere salvato, come alcuni passi di testi sacri o un particolare petalo di un fiore – e non voglio soffermarmi troppo su tutte le valenze simboliche che ha il petalo. Il colore, oltre alla questione del simbolismo del blu, è quella materia che mi permette di riprodurre sulla superficie tutte queste valenze. Per quanto riguarda il rullo, lo utilizzo ancora oggi, mi ricorda che il mio è un lavoro quasi da artigiano, e quel “quasi” che lo separa dal lavoro dell’artigiano – dell’imbianchino, nella fattispecie – è il diverso grado di consapevolezza di ciò che entrambi stiamo facendo, ovvero coprendo una superficie di colore. E sì, il rullo mi ha sempre garantito il maggior distacco possibile dalla gestualità della pennellata: così, se sono stanco o riposato, sereno o arrabbiato, sazio o digiuno, questi estemporanei e inutili dettagli personali non si trasferiscono sulla tela tramite la pennellata, ma vengono attutiti dal rullo.
d.a.c - Infine colore=luce; dove finisce l'uno e dove comincia l'altro, poiché se è vero che il fare pittura si serve del colore (anche del bianco che proprio colore non è) e delle sue gradazioni, dall'altro la luce assume la sua definitiva totalità solo quando termina l'azione creativa, quando cioè l'opera diventa un oggetto pronto allo sguardo dello spettatore e alla riflessione dell'artista? G. Z. -Ora che mi ci fa pensare, mi ricordo che negli anni settanta questa storia della “luce” mi costò un’importante mostra allo Stedelijk Museum di Amsterdam, “Fundamental Painting”. Rini Dippel che curava la mostra aveva visto le mie opere intitolate “Luce bianca su tot linee verticali” o “su tot linee orizzontali”, e fraintendendo aveva pensato che a me, in un quadro, interessasse la luce. In realtà quella “luce bianca” non è altro che la traccia dell’ultima mano di bianco che era prevista in sede progettuale del dipinto: arrivato a quel punto, decidevo che l’opera era finita così, e dell’ultima mano restavano quei segni. Quindi, all’epoca “luce” e “colore” erano per me concetti per certi versi sovrapponibili. Oggi il tema della luce in quanto tale mi interessa di meno, mentre mi interessa il colore inteso come variazioni di intensità luminose. Non che mi interessi di cromatismo, certo che no, ma credo che le tonalità differenti dei colori dei miei quadri più recenti debbano essere considerate diverse intensità di consapevolezza. Ma questa è un’altra storia, e ne parleremo un’altra volta.
|
|
|
giugno - luglio 2013
|
Nel segno dell’uomo
PArCo - Galleria d’arte moderna e contemporanea di Pordenone “A. Pizzinato”
La mostra, che per certi versi può essere definita il percorso pittorico di Armando Pizzinato, tiene ancor viva, proprio per la forza delle opere esposte, una storia che il maestro veneziano ha voluto attraversare personalmente. Le "vecchie polemiche" – non so se possono essere relegate alla storia italiana e alla storia dell'arte - sono, in questa esposizione, ancora vive. Sono le testimonianze di un uomo che ha vissuto, attraverso l'espressione artistica, ciò che la vita gli ha riservato; con la pittura ha espresso quel senso di responsabilità politico-sociale che ha naturato e intensamente vissuto in un'epoca ricca di immaginazioni e progetti e stimolatrice di forti sperimentazioni estetiche. «Non un divenire sul "tutto scorre" e basta, ma un divenire sul "conoscere" per agire, agire per modificare, modificare per essere modificati», si legge su uno dei pannelli che accompagna la mostra. Duplice l'intenzione: un modificare la coscienza civile legata al mondo del lavoro (i cui simboli s'intravvedono, energici e dinamici, ancora nelle Composizioni degli anni novanta) e un modificare il percorso espressivo di un artista sempre attento alle mutazioni dell'espressività linguistica. La mostra accoglie l'intero percorso creativo dell'artista, originando dalle pitture giovanili nelle quali il paesaggio, la natura morta, le figure e i ritratti già definiscono "a priori" l'intero interesse comunicativo. La progressiva elaborazione degli stili pittorici denota profonde attenzioni verso le mutevoli correnti artistiche che si sono alternate nel corso della sua formazione. Il Futurismo, la Metafisica, il Neocubismo, l'Espressionismo tedesco, da punti di riferimento si sono gradualmente trasformati in momenti di personale e intima riflessione linguistica. Il loro progressivo amalgamarsi nella visione estetica di Pizzinato, si muove parallelamente alla ricerca di una coscienza esistenziale sorretta da una consapevole funzione sociale e politica della pittura. Che non può annoverarsi esclusivamente nella semplice narrazione (come i grandi cartoni per gli affreschi o le descrizioni degli umili lavoranti potrebbero fuorviare lo spettatore) ma nella coscienza che l'arte e la pittura appartengono a una realtà culturale che non può essere esclusivamente relegata a una mera funzione estetica. Si legge in quelle sentite opere degli anni cinquanta e sessanta, la coscienza di un uomo che guarda all'idealità, alla necessità di appartenere a una parte del mondo. Un'idea di realtà sociale condivisa dai grandi storici dell'arte di allora, dai Brandi, dai Bianchi Bandinelli o da quell'Argan, che dell'artista scrisse: "Da quarant'anni Pizzinato è per me un amico taciturno e malinconico, talvolta scontroso, ma di un'umanità giusta e sicura, da uomo del popolo". Si legge, nelle opere di Pizzinato, la consapevolezza che il linguaggio pittorico non può essere solamente espressione di un rapporto con il mondo esterno, come sottolineò a suo tempo lo stesso Argan nel riflettere sulle raffigurazioni dei paesaggi liguri o dei gabbiani o delle betulle; volle, infatti, pensare a un Pizzinato che guarda all'infinito e contemporaneamente dentro se stesso, lasciando alla gestualità o all'immediatezza dell'atto pittorico il compito di definire, attraverso delle simbologie segniche, il proprio io. Non una pittura di cuore dunque, ma una pittura che riflette il suo esistere contemporaneamente nel tempo, nel ciclo evolutivo delle cose e della mutazione del linguaggio della pittura.
|
|
|
febbraio - marzo 2013
|
Livorno
Diego A. Collovini - Come hai iniziato, con chi, quali gli stimoli e le ragioni che ti hanno fatto scegliere questo lavoro? Roberto Peccolo - Sono nato a Livorno nel 1942 Sono dello Scorpione. Ho sempre vissuto e lavorato con la mia Galleria a Livorno. Sin da giovanissimo lavoravo nel negozio di mio padre, noto antiquario di Livorno. Nel 1962/63 ho iniziato a interessarmi all'Arte Moderna e Contemporanea. Nel 1968 ho cercato di aprire uno spazio all'interno del negozio di mio padre, dove mostrare ai clienti opere d’Arte Moderna. Poi dal maggio 1969 mi sono dedicato esclusivamente all’Arte Contemporanea aprendo quindi la Galleria Peccolo nella sede già esistente, in piazza Repubblica 12 Livorno, e iniziando così un'ininterrotta serie di mostre personali dedicate ad artisti contemporanei italiani e stranieri che ha superato, a tutto oggi, la 350ma mostra.
d.a.c - La tua galleria per diversi anni è stata considerata una galleria di tendenza e conosciuta per aver privilegiato la pittura degli anni settanta, tanto che hai avuto importanti scambi con gallerie tedesche, francesi e olandesi e portato in Italia artisti di fama internazionale anche statunitensi. r. p. - L’ambiente dell’arte, come spesso anche la critica d’arte, per semplificarne la spiegazione sceglie di contrassegnare le cose e gli avvenimenti in base a etichette facilmente e brevemente riassumibili. Ma di solito le cose non sono poi così semplificabili. Infatti, il "vero e reale" filo conduttore delle mostre e degli avvenimenti che ho organizzato nella mia galleria è sempre stata una mia personale riflessione sull'Arte Contemporanea e sulla ricerca artistica, italiana e non. Quella, per capirci, che è susseguita al Futurismo (vorrei dire fino ad oggi, anche se in questi ultimi 10 anni tutto è molto, troppo, cambiato). Comunque è vero che durante gli anni ’70 ho esposto spesso pittori che esploravano le possibilità, più o meno analitiche o liriche, di fare Pittura. E poi molti di questi, anche recentemente, sono stati riuniti in mostre sotto l’etichetta di Pittura Analitica. Ma la realtà dei fatti era che quei coraggiosi Pittori, allora quasi monocromi, avevano il coraggio di ritornare al quadro dipinto e alla pittura in un momento in cui tutto il mondo dell’arte guardava con venerazione all'Arte Concettuale. Dipingere su tela col pennello, durante quegli anni, era considerata un'eresia. Alcuni pittori con cui ho lavorato in quegli anni sono stati poi invitati nel 1977 alla prestigiosa rassegna Documenta 6 di Kassel. Ma già dal 1973/74 avevo iniziato rapporti di amicizia e collaborazione con Galleristi e Direttori di Musei (Tedeschi, Olandesi, Belgi) con i quali ho organizzato numerose mostre, sia di questi pittori come anche di altri artisti di cui stimavo il lavoro.
d.a.c - Se guardiamo però alla tua storia non si può dire che la tua attività si sia limitata alla sola pittura. r. p. - Non mi sono mai soffermato più di una o due stagioni a esporre un pittore o un unico tipo di pittura o un singolo gruppo artistico. Ma ho sempre continuato a muovermi tra gli artisti e le situazioni artistiche della storia dell’Arte d'Avanguardia degli ultimi 60 anni. A più riprese ho promosso in galleria Festival di musica (jazz e altro) performance (teatrali o di danza) installazioni, conferenze (la più famosa è stata quella, nel marzo 1980, in cui ho chiamato Filiberto Menna, Germano Celant e Achille Bonito Oliva a tenere in 3 sere diverse una conferenza ciascuno sul tema "La riflessione della critica").
d.a.c - Quanto, secondo te, i collezionisti possono influenzare le scelte di un gallerista e quanto le scelte del gallerista possano influenzare il mercato? r. p. - Prima di presentare in galleria un artista ho guardato e analizzato il suo lavoro e la sua storia: ho già fatto una scelta. Mi è piaciuto, quindi lo espongo, quasi dicendo ai visitatori: guardatelo e se vi piace compratevelo. Alle persone che entrano in galleria e guardano le opere, continuo a dire…questo è un artista di tale età; che ha avuto una tale storia artistica e personale oppure che in quegli anni faceva questo e ora sta lavorando al tema qui esposto in mostra. Secondo me un’opera assolve pienamente a una delle sue primarie funzioni quando, dopo averla vista (anche senza averla comprata) ti costringe a cercare un libro o un disco per ampliare la tua comprensione nei suoi confronti. Invece per molti oggi l’opera è "interessante" soltanto quando raddoppia o decuplica il suo prezzo durante un'asta internazionale. Riguardo ai giovani artisti di oggi non mi sembra che questi abbiano molto bisogno di essere aiutati, anzi mi sembra che siano anche troppo "coccolati"; gli sono tutti intorno, come alle galline, ad aspettare che vengano fuori le uova d’oro. La maggior parte di loro sanno mettere in pratica e utilizzare le tante strategie, ormai ben conosciute da tutti, per ottenere il successo e la gloria. Ma secondo me questo è proprio il sistema più sicuro per NON fare arte. L’arte, quando è sincera, non ha strategie, è indifesa ma soprattutto non ha niente a che spartire con gli oggetti fatti per un mercato dell’arte.
d.a.c - La crisi economica ha indubbiamente limitato la promozione e la divulgazione delle attività artistiche, secondo te, questo potrebbe essere un momento di riflessione e pensare a nuove forme di comunicazione? r. p. - Mi sembra il contrario, cioè direi che oggi la volontà di autoaffermazione degli artisti e dei loro galleristi o manager per ottenere sempre maggior numero di ascolti e conquistare sempre più ampie fette di mercato stia spingendo agli estremi qualsiasi forma possibile di pubblicizzazione delle opere e del contesto. Il valore odierno dell'opera è dato dalle quotazioni del mercato o, meglio, dai listini di vendita delle aste. Oppure dall'eclatante effetto o dallo scandalo che suscita nell'opinione pubblica. Non è un caso che, oggi, alcuni degli artisti più famosi e pagati provengano dal mondo della pubblicità. E non solo loro, anche alcuni mecenati hanno questa stessa provenienza culturale.
L d.a.c - a tua esperienza porta a considerazioni al futuro, come vedi la ricerca artistica attuale? Hai visto l'ultima biennale… r. p. - Dell’ultima Biennale veneziana, quella di Sgarbi per capirci, preferisco non parlare. Sarà meglio stendere un velo pietoso sopra quel cumulo di macerie che il Curatore è riuscito a produrre pur di mettere in risalto la sua megalomane personalità. Semmai mi ha molto meravigliato come molti artisti già affermati abbiamo accettato passivamente che la loro opera venisse esposta in quel contesto. Per quanto riguarda il futuro dell’arte o nomi di artisti mi sembra inutile parlarne, l’unica cosa che continuo a dire e pensare che non potremo continuare a dimenticare o cancellare il passato e la storia degli avvenimenti che si sono susseguiti nel secolo scorso (dagli impressionisti del 1860 fino al 1999). Prima o poi dovremo fare i conti con tutto quello che è stato fatto e QUANDO è stato fatto. Dovremo, un giorno, riconoscere e dare a Cesare quello che appartiene a Cesare. Non credi ??
d.a.c - Cosa pensi delle aste, delle quotazioni che ne escono dalle battute, e le fiere rispondono ancora alla loro primaria funzione visto che se ne inventano in continuazione? r. p. - Io ho sempre rifiutato di partecipare a Fiere e Mercati dell’Arte, già la parola stessa li qualifica. Ma anche le Aste sono parte integrante di questo sistema a senso unico: trasformare le opere d’arte in mero prodotto di consumo. In questo sistema avevo sempre intravisto un decadimento dell'opera d’arte a mera merce da vendere. Sia per la formula con cui viene esposta e trattata che per il concetto di fondo che ne cancella ogni potenzialità di "pensiero". Se continua così, l’essenza di un'opera d’arte, non conterà più e non conteranno più nemmeno le ragioni per cui questa viene fatta, i "perché" del fare verrà (lo è già stato) soppiantato dal prodotto artistico realizzato da tanti bravi artigiani ma che niente avranno a che fare con l’arte e l’artista.
|
|
|
febbraio - marzo 2013
|
Dai tracciati Urbani Palazzo degli Alessandri - Viterbo
L'antologica allestita nel medioevale palazzo degli Alessandri di Viterbo vede esposto il percorso creativo di Alfonso Talotta. Un percorso iniziato nel 1979, con l'artista ancora giovanissimo (è del 1957), fino ai recentissimi dittici. Un'antologica che mette lo spettatore di fronte a una serie di opere che esprimono il pensiero evolutivo che guida la logica trasformazione e evoluzione del linguaggio dell'artista viterbese. Ci sembra inutile, almeno in questa sede, ripercorrere le diverse tappe della sua ricerca, forse ci è sufficiente soffermarci su alcuni momenti, i più significativi forse, a partire dalle prime opere quasi concettuali. Allora Talotta registrava su tela il segno/traccia lasciato dai copertoni della sua Dyane. Era quello il periodo dei Percorsi urbani. E sebbene queste opere non appartenessero a un'azione meramente pittorica, le stesse opere portarono l'artista a riflettere sulla linea e sulla contrapposizione tra il bianco e il nero. Le stesse indicazioni espressive verranno poi elaborate in pittura, rientrando così nella sfera dell'interesse di Filiberto Menna. Fu lui che, molti anni fa, mostrò attenzione per l'evolversi della ricerca di Talotta, tanto che il critico lo volle nel gruppo che denominò Astrazione Povera; e a lui riconobbe "la capacità di articolare la superficie mediante forme appena accennate, sfuggenti e precarie che non devono proprio nulla alla moda recente delle nuove geometrie." Dunque una pittura rigorosa, essenziale e intimistica poiché figlia di una meditazione attenta più all'effetto che questa procura nello spettatore, che a ogni considerazione di tipo progettuale; e così "figure astratte e bianche, luoghi dell’assenza ma non privi di ragione pittorica, forme svuotate di materia che contrastano con il nero dipinto e saturo" (Cerritelli) diventano spazi sui quali ancora riflettere e progettare il futuro. Linee o perforazioni che interrompono il piano pittorico e ne esaltano le tramature della pennellata e le trasparenze del colore. La ricerca lo porta poi alla realizzazione di una forma nata dal movimento di un segno, realizzata non più da una linea ma dalla divisione di due campi cromatici. Un segno che si fa forma iniziando quel gioco dialettico delle contrapposizioni; se da un lato vi è la separazione tra campo cromatico e supporto della superficie, dall'altro - e questo è maggiormente evidenziato dalle opere in ceramica - viene ulteriormente sottolineando, e con decisione, la contrapposizione tra presenza e assenza, tra vuoto e pieno, tra colore e non colore. La ricerca pittorica lascia lo spazio a nuove proposte, che lo accompagnano a nuove esplorazioni, come la sua recente materializzazione dell'idea di duplice. Infatti, la duplice visione dello spazio si manifesta nella presenza contemporanea di due opere o di due forme contrapposte o complementari; ed entrambe contribuiscono a definire l'ambiguità di un'apparente continuità formale di una figura ancora una volta sottolineata nel dialettico rapporto tra colore e superficie.
|
|
|
febbraio - marzo 2013
|
Galleria Peccolo - Livorno
Nella diversificata attenzione che Peccolo riserva al mondo dell'Arte contemporanea, ogni tanto riguarda alle esperienze passate proponendo artisti legati alla pittura, ma certamente non con l'occhio rievocativo di una ricerca oramai storicizzata, ma mettendo in evidenza l'evoluzione (necessaria per l'artista) di un ciclo espressivo che si pone quale testimone dell'operatività evolutiva di un pittore anche attraverso le osservazioni di Flaminio Gualdoni che ne ha curato il catalogo. È, infatti, ospite nella storica galleria di Livorno Sandro De Alexandris. Pittore ed esponente di quel periodo che va sotto la definizione di Pittura analitica (ne tralasciamo in questa sede ogni altra definizione, tenendo presente che potremmo condividere, seppur nella sua generalizzazione, la definizione di Celant usata nel 1967 quando parlando di alcuni artisti americani, fra i quali Martin e Ryman, scrisse di una "pittura che da sistematica si fa analitica"). Il rapporto con questo movimento (che definirei piuttosto un'esperienza multipla di singoli artisti che di volta in volta venivano invitati a rassegne, nelle quali il critico di turno ne esplicava l'aspetto estetico e forniva indicazioni per una lettura individuale) è stato, per ogni pittore, diverso e personale, comunque non pensato in modo aprioristico. Queste conoscenze hanno dato occasione all'artista di sperimentare le potenzialità espressive di questo linguaggio nella convinzione che il risultato del fare non potesse essere stabilito razionalmente, ma venisse considerato come un processo creativo in itinere, un concetto artistico riconoscibile quale risultato ultimo e quale conseguenza di un linguaggio individuale con una sintassi espressiva efficace in grado di ripensare continuamente l'atto pittorico. Comunque le opere di De Alexandris possono essere ascritte al quel tipo di pittura che si trasforma da progetto a linguaggio; un fare pittura in grado di guardare a se stessa per elaborare una forma linguistica valida non per ciò che può raccontare o descrivere, ma per la potenzialità espressiva degli elementi che la compongono. Un costruire la pittura in forte sintonia con quanto Filiberto Menna ne La linea analitica dell'arte moderna aveva così ben esaminato. Seguendo le indicazioni dell'autorevole critico, possiamo soffermare la nostra lettura sia sugli elementi che concorrono alla definizione della pittura come il telaio, la tela, il colore, la materia, sia sul procedere materialmente, sulla pratica del fare. Un "esercizio della pittura", quello dell'artista, che palesa dapprima l'analisi delle componenti che caratterizzano la pittura in quanto tale, poi si sofferma sul processo del fare concretamente pittura, sfruttandone tutte le potenzialità espressive. Anzi a dare una definizione efficace di come intenda la pittura è lo stesso De Alexandris che ce la suggerisce: "Colore che copre colore, che svela colore. Cancellazione e svelamento sono le condizioni visibili della superficie, che chiede di essere rivelata così, nella sua essenza, nel suo essere qui." Potremmo, seguendo le sue parole, pensare che la sua ricerca tenda a privilegiare due elementi linguistici: la superficie e il colore, senza con questo escludere, aprioristicamente, ogni interferenza, voluta o meno, di altri elementi. Ma una tale scelta ci porterebbe verso una lettura riduttiva del suo lavoro. Sono, infatti, i titoli delle opere che ci offrono un'ulteriore e possibile interpretazione del suo lavoro. Soglia, stanza, giardino sono titoli che ci richiamano alla mente degli spazi, mentre aurora, indocile rosso, aura, verso l'ardesia guardano invece al colore o meglio alla luce. Suggerimenti che alternano spazi chiusi con altri termini che al contrario richiamano all'infinto. E così il finito potrebbe identificarsi nella materialità del colore, mentre infinita ci può apparire la luce; termini che in realtà si presentano come un momento di sintesi nell'oggettivo lavoro dell'artista: pigmenti colorati che delimitano la spazio pittorico come momento propulsore che introduce alla ricerca della luce che, pur materializzandosi sulla chiusa superficie bidimensionale, si fa protagonista di un gioco percettivo che coinvolge lo spettatore introducendolo in uno spazio immaginario quasi estraneo a quello materiale. Una proposta espressiva che muove dal dialogo originato dalla varietà delle tonalità cromatiche e dall'assonanza coloristica fino a riportare alla mente i primari monocromi di altri anni, ormai passati. Un esercizio della pittura dunque che si esprime non nella totalità della superficie – che presuppone l'idea di infinito - ma nella divisione spaziale del piano pittorico. Linee perpendicolari dividono la superficie, creano cornici, delimitano lo spazio dedicato al colore che viene steso con diverse intensità. Si può osservare, in altre sue pitture, il colore scendere quasi a cascata, diluendosi, senza mai coprire completamente lo spazio bianco, altre volte nell'intersezione delle linee, l'artista stende i colori in modo tale da creare illusorie prospettive e apparenti strutture geometriche. De Alexandris ci accompagna quindi alla visione delle sue opere non esprimendo considerazioni o spiegazioni della sua pittura – questo lo fa con opportune considerazioni a margine delle pubblicazioni che lo riguardano - quanto piuttosto manifestando le sue personali riflessioni, anche interiori, sulle potenzialità espressive della luce che si rivela nel dialogo tra la superficie e il colore. Questo ci permette di guardare alle sue opere, non come un modo di lavorare quasi seriale, ma come quel lento succedersi dell'esercizio della pittura che induce, proprio nel suo alternarsi o succedersi nel tempo, alla sperimentazione degli effetti del colore sulla luce.
|
|
|
febbraio - marzo 2013
|
il colore della materia Galleria Nuovo Spazio - Udine
Osservando le opere di Luca Giacobbe ci appare spesso difficile distinguere quale sia il ruolo del colore e la funzione della materia. L'artista si esprime con una pittura grassa, contraddistinta da minime forme spesso ridotte a ristretti segni, altre volte viene esprimendosi in contenute campiture ben delineate, che dialogano con la superficie; avvertiamo nelle sue opere altre presenze segniche che, pur nella loro semplicità realizzativa, rimandano a un'idea di ricomposizione dello spazio pittorico. Ma nessuno di questi componenti gioca il ruolo da protagonista, nessun elemento linguistico, che costituisce la pittura di Giacobbe, va a caratterizzare in modo esclusivo l'opera dell'artista fiorentino. Questo gli permette di operare liberamente senza condizionamento, a volte muovendo dal segno, altre dalla scelta del colore o ancora originando il suo pitturare da una preordinata figura che introduce la composizione. Vi è sempre nell'artista la consapevolezza che se da un lato dipingere risponde a una precisa autonomia del fare, dall'altro la stessa muove alla ricerca di un equilibrio definitivo, ben diverso da quello manifestato dalle esperienze passate, come quelle dell'espressionismo astratto che ha contrassegnato gli anni cinquanta del secolo scorso. Né, proprio per un'intimità progettuale, Giacobbe ripercorre le tematiche affrontate pochi anni dopo nel nord Europa mediante un'accentuata figurazione materica; e così la volontà di elaborare un personale linguaggio espressivo lo tiene consapevolmente distante dall'uso di quel colorismo di tipo naturalistico–paesaggistico che ha contrassegnato una certa parte dell'astrattismo italiano. Giacobbe alterna ampi cromatismi ad accentuate trasparenze o ad amalgame improvvise; mentre l'immediata gestualità, pur esprimendosi all'interno di uno spazio bidimensionale contenuto, va ipotizzando immagini che muovono alla ricerca di spazi virtuali disegnati da un ipotetico percorso segnico che sembra oltrepassare i limiti della superficie. Una pittura consapevolmente elaborata all'interno della bidimensionalità della tela, ma sorretta dalla certezza che più la superficie si ricopre di tenui cromaticità e trasparenze, tanto più coinvolge lo sguardo dello spettatore per trattenerlo in uno stato di attenzione alla ricerca delle vibrazioni e delle vaghe definizioni cromatiche che gradualmente si vanno materializzando. Per questo la sua pittura ci appare controllata sempre però come espressione di un atto liberatorio che va ad attualizzarsi in un immediato dialogo con la materia, con lo spazio relativo della superficie e con quello più ampio dell'immaginazione, come in uno stato di perenne attesa sostenuto dal persistere di un colorismo che si manifesta quasi come un'assenza, come aspettativa di un essere ancora da venire, sempre però in un aperto dialogo con una materia grassa, capace di registrare e contenere con forza la gestualità pittorica di Giacobbe. Consapevole delle qualità della materia, la satura con dei colori forti, vivaci e spesso inusuali (rosa, verdi o gialli), offrendo loro la massima lucentezza; ed esprimendo nel contempo la riservatezza che appartiene alle trasparenze o alle velature, attraverso le quali colori chiari e caldi danno alla luce una certa intensità. Una luce a volte soffocata ma comunque presente con un filo di colore che la fa apparire come una realtà lontana o illusoria. Le sue opere, nelle quali l'artista alterna figure dai colori freddi con ampi cromatismi dai caldi colorismi, si vengono a definire come momenti di sintesi di una piacevole contrapposizione tra elementi corporei e scatti cromatici che, senza un ordine preciso e silenziosamente, si delineano sulla superficie, esprimendo così un atto creativo che mescola il sentimento con l’azione: un fare pittura dunque, che, attraverso il movimento, l’energia, la materia, si è resa interprete di uno stato emotivo ed esistenziale.
|
|